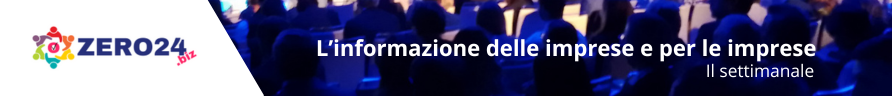La guerra distrugge il presente e avvelena futuro, persone e comunità, terra e prodotti. E se non c’è terra non c’è speranza. In Palestina, ha ricordato il fondatore di Slow Food Carlo Petrini nel corso dell’inaugurazione di Cheese, «il dazio più grande lo sta pagando la società civile, lo stanno pagando le donne e i bambini. Fame e malnutrizione sono usate come armi di guerra». Quel che sta accadendo poco distante dal centro dell’Europa mediterranea stravolge ciò che il cibo ha da secoli rappresentato: una fonte di vita, un mezzo di comunicazione e di connessione tra le persone, uno strumento per costruire comunità e identità.
Cheese è dedicato ai formaggi, ma non per questo dimentica o ignora quel sta succedendo nel mondo. L’evento, fin dall’apertura ufficiale, ha riaffermato con forza il diritto al cibo per tutte e tutti e ha poi previsto alcuni momenti molto speciali, dedicati al Medio Oriente e al percorso necessario per riportare la pace in Palestina.
Insieme a VIS-Volontariato Internazionale per lo sviluppo, nell’ambito del gemellaggio tra il Comune di Bra e la Città di Betlemme, sono stati presentati i progetti dei vini dei Salesiani di Cremisan e della Scuola Juzoor in Cisgiordania. Il progetto dei vini dei Salesiani del Monastero di Cremisan (25 ettari e 250.000 bottiglie), vicino a Betlemme (in Cisgiordania), è nato per sostenere le opere salesiane locali: scuole, centri giovanili e un centro culturale. Ogni bottiglia racconta una storia di resilienza, tradizione e speranza. Purtroppo questa realtà, importante per la vita di molti palestinesi, sta attraversando grandi difficoltà, inoltre gli attacchi israeliani hanno bloccato il turismo in Terra Santa e le esportazioni: «Quest’anno, per dare un segno di speranza, abbiamo di nuovo vendemmiato e vinificato – spiega Luca Cristaldi del Vis – e stiamo provando a vendere qualcosa all’estero. Con Slow Food cerchiamo di creare una rete di distribuzione anche in Italia». Il Monastero si trova esattamente a cavallo del muro israeliano, lungo il confine della Cisgiordania. Cemento armato e filo spinato dividono in due la proprietà, i terreni da una parte e la struttura abitativa e di vinificazione dall’altra. «Grazie alla cooperazione italiana – spiega Raoul Tiraboschi, vicepresidente di Slow Food Italia – si è riusciti a identificare le varietà autoctone, vinificarle e produrre un vino eccellente. Un vino che è un ponte tra culture, simbolo di ricostruzione di una comunità fortemente minacciata».
Scuola Juzoor è il nome del secondo progetto raccontato a Cheese. L’obiettivo è la costruzione di una scuola primaria nel villaggio di Khallet Taha, a sud di Hebron, la ristrutturazione di quattro istituti in Cisgiordania e il supporto psicosociale a studenti e insegnanti. Al progetto partecipano attivamente anche Slow Food e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: «È un atto di giustizia, un presidio contro un sistema che cerca di cancellare la memoria storica e culturale del popolo palestinese» spiega Petrini.
Cheese ha avuto anche l’onore di ospitare la cuoca e divulgatrice palestinese Fidaa Abuhamdiya. Fidaa ha 36 anni, vissuti tra Padova ed Hebron. Nata a Jabalia, nella Striscia di Gaza, in Italia ha studiato e lavorato in ristoranti rinomati, come il pluristellato ristorante Le Calandre di Sarmeola. Per lei, insegnare a cucinare è una forma di riscatto per un popolo umiliato, un modo per garantire unità in un contesto di diaspora e occupazione, uno strumento di emancipazione delle donne che da sempre conservano la grande biodiversità gastronomica di questo piccolo Stato. «È difficile – spiega Fidaa – parlare di cibo e pace in Palestina, mentre si cerca di sopravvivere con quel poco che c’è a disposizione e il cibo è usato come un’arma. Che cosa vuol dire la pace in questo senso? Sedersi a tavola e mangiare un piatto in compagnia senza pensare alle bombe che cadono accanto. Non dover fare i conti con le difficoltà del procurare qualcosa da mangiare. Tornare a coltivare la terra, raccogliere le olive e camminare tra le colline alla ricerca di erbe selvatiche da usare in cucina».
Nonostante la situazione drammatica, Fidaa continua a pensare che il cibo sia uno strumento prezioso per raccontare la sua Palestina: «È una parte fondamentale della cultura di un popolo. Il cibo racconta le abitudini, la terra e tutto quello che la terra offre, e come le persone abbiano saputo trasformare questi doni in piatti che contengono storie e ricordi. La gastronomia racchiude tradizioni e simboli, è espressione non solo delle festività ma anche dei momenti di lutto». Lo dimostra il suo recente libro Pop Palestine, non solo un ricettario, ma un vero e proprio viaggio nella cultura e tradizione culinaria palestinese: «Ci sono ricette che abbiamo ereditato dai nostri antenati Cananei, piatti che sono il frutto della contaminazione di altre culture e piatti che uniscono tutto il popolo palestinese, indipendentemente delle religioni professate. Pensiamo a ricette come l’hummus, la maqluba, l’akkub e lo zaatar: piatti e ingredienti che raccontano la Palestina, ma che spesso vengono decontestualizzati e spogliati della loro origine. In Palestina anche cucinare un piatto tradizionale in una casa palestinese sotto occupazione è un atto di resistenza, così come è un atto politico andare a raccogliere lo zaatar e prepararlo. Il cibo, per i palestinesi nella diaspora, è un ponte per non dimenticare la propria terra, per tramandare e raccontare la Palestina che vive nei ricordi familiari».
«Slow Food continuerà a lavorare per affermare ogni giorno che il cibo deve essere un diritto per tutte e tutti, uno strumento di pace e benessere, e che non può e non deve mai diventare strumento di guerra e di morte. Per questo aderisce, anche quest’anno, alla Marcia per la Pace Perugia Assisi del 12 ottobre» ha dichiarato Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia.