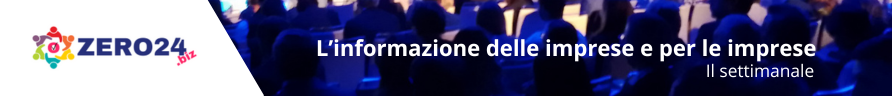di Christopher Keating, Senior Vice President, Transportation and Logistics Segment di Trimble
Con l’avvicinarsi del nuovo anno e la chiusura del 2025, il settore dei trasporti e della logistica si trova di fronte a un panorama in continua evoluzione, dove le opportunità si moltiplicano e le sfide non mancano. L’incertezza economica e le tensioni geopolitiche restano elementi di instabilità, mentre l’innovazione tecnologica continua a procedere a un ritmo senza precedenti.
In questo scenario complesso, la capacità di adattarsi rapidamente diventa il vero vantaggio competitivo. Le aziende destinate a guidare il cambiamento saranno quelle che sapranno integrare l’intuizione umana con la trasformazione digitale, costruendo al contempo una resilienza operativa in grado di affrontare le dinamiche sempre più globali della supply chain.
Alla luce di queste premesse, ecco le cinque principali tendenze che, secondo noi, definiranno il settore nel 2026.
1. Intelligenza artificiale: dall’hype alla collaborazione basata sui dati
Il rapporto del settore con l’intelligenza artificiale sta raggiungendo una nuova fase di maturità e, dopo un periodo di sperimentazione, si entra ora nell’era dell’utilizzo concreto, con una progressiva riduzione del divario tra le piccole e medie imprese, grazie ad una tecnologia sempre più accessibile.
entra ora nell’era dell’utilizzo concreto, con una progressiva riduzione del divario tra le piccole e medie imprese, grazie ad una tecnologia sempre più accessibile.
Nel 2026, l’IA sarà parte integrante delle applicazioni operative quotidiane, trovando spazio negli ambiti della manutenzione predittiva, dell’ottimizzazione delle reti logistiche e della definizione dinamica dei prezzi. Inoltre, le conversazioni sull’autonomia completa stanno già prendendo piede anche a livello operativo e non sono più confinate alle sole discussioni dell’area IT.
L’espressione “IA come collega” sta progressivamente sostituendo quella di “IA come strumento”, a dimostrazione del fatto che le aziende non si interrogano più sull’utilità dell’intelligenza artificiale, ma si chiedono piuttosto “cosa può fare l’IA e con quale rapidità può farlo”. L’obiettivo quindi non è quello di sostituire le persone, bensì quello di liberare tempo e risorse per affidare a queste ultime le attività a maggior valore aggiunto.
La sfida più grande resta la qualità dei dati, un tema rilevante nel settore da anni, che oggi viene finalmente riconosciuto come il vero fattore abilitante dell’automazione. Le pressioni economiche spingono le aziende a prendere atto di una verità ormai ineludibile: se si vuole un’IA realmente autonoma, occorre prima investire sui dati che la alimentano. Senza dati puliti e affidabili, su quali basi possiamo costruire il futuro?
2. Il fattore umano: la sfida del cambiamento
La carenza di autisti continua a rappresentare una criticità significativa, così come la crescente attenzione verso sicurezza, comfort e inclusione. Tuttavia, la sfida più ampia che il settore si trova oggi ad affrontare riguarda la gestione del cambiamento in sé.
Una frase ricorrente tra i responsabili operativi che valutano l’adozione dell’intelligenza artificiale è: «Abbiamo persone che svolgono questo lavoro da trent’anni e non sappiamo come reagiranno.» La vera integrazione dell’IA dipende infatti dalla disponibilità del personale – abituato a processi consolidati – ad accogliere trasformazioni profonde nel modo di lavorare.
Le aziende di maggior successo stanno comprendendo l’importanza di nominare “ambasciatori del cambiamento” all’interno dei propri team: figure esperte che fungano da ponte tra i processi tradizionali e le nuove tecnologie, figure dedicate ad accompagnare i colleghi nella transizione con credibilità, empatia e competenza.
Nel contesto attuale, la customer experience si conferma un elemento chiave di differenziazione. In particolare, il modello “uomo più IA” si sta dimostrando essenziale per un’adozione efficace delle nuove tecnologie. Gli esempi concreti non mancano: assistenti digitali in grado di riconoscere le lingue, tradurre comunicazioni, smistare richieste e segnalare anomalie stanno già contribuendo ad accelerare i tempi di risposta e a migliorare la qualità del servizio.
Le aspettative dei clienti sono infatti aumentate sensibilmente: abituati all’immediatezza e alla semplicità delle esperienze nei settori retail e bancario, oggi non si accontentano più di ricevere notifiche sui problemi, ma si aspettano soluzioni proattive e interventi automatici.
In definitiva, la tecnologia evolve rapidamente, ma le persone devono evolvere altrettanto in fretta e investire sulle persone non può più essere un aspetto accessorio della trasformazione digitale: deve esserne il fondamento.
3. Sostenibilità e intermodalità: progresso attraverso il pragmatismo
La transizione verso fonti energetiche alternative prosegue, ma la diffusione su larga scala dei veicoli industriali elettrici e a basse emissioni resta condizionata da carenze infrastrutturali e da fattori economici che ne limitano la redditività complessiva.
Tuttavia, alcuni segmenti stanno registrando un’adozione anticipata: nelle operazioni di distribuzione urbana in diverse aree d’Europa, l’elettrico sta diventando sempre più competitivo in termini di costo totale di proprietà, aprendo nicchie operative dove sostenibilità e convenienza economica si incontrano.
Per il mercato più ampio, invece, le aziende stanno privilegiando interventi ad alto impatto e basso investimento, in grado di generare contemporaneamente efficienza economica e riduzione delle emissioni. Tra questi rientrano la pianificazione dinamica dei percorsi, il monitoraggio intelligente della pressione degli pneumatici e la dematerializzazione dei flussi documentali.
In sostanza, sostenibilità e redditività non rappresentano più obiettivi distinti, ma un unico traguardo strategico che guida le decisioni operative.
Sul fronte dell’intermodalità, invece, la crescita continua a essere frenata dalla complessità dei processi. Se il trasporto su gomma coinvolge in media tre attori, quello intermodale ne richiede almeno sette, con un conseguente aumento di variabili gestionali.
La principale barriera resta l’incompatibilità dei dati: le diverse modalità – marittima, ferroviaria, stradale e aerea – utilizzano standard tecnologici eterogenei, che ostacolano la piena interoperabilità dei sistemi. In questo contesto, l’intelligenza artificiale può rappresentare un fattore abilitante, grazie a strumenti di pianificazione e ottimizzazione capaci di armonizzare i flussi informativi e migliorare la visibilità end-to-end delle catene logistiche.
A livello globale, tuttavia, le infrastrutture datate e i ritardi nella manutenzione e nell’ammodernamento – dai colli di bottiglia ferroviari in Europa ai cantieri stradali in Nord America – continuano a limitare capacità, affidabilità e prevedibilità operativa.
4. Resilienza e volatilità: una nuova condizione strutturale
Le tensioni geopolitiche e la crescente multipolarità dei mercati continueranno a influenzare le catene di approvvigionamento in modo imprevedibile. Anche se la volatilità tariffaria sembra aver raggiunto un picco – o, più probabilmente, le aziende hanno imparato a introdurre meccanismi di salvaguardia contro variazioni improvvise – il livello di incertezza strutturale resta elevato e costante. In questo scenario, le imprese possono trarre vantaggio dall’adesione a reti logistiche flessibili e basate sui dati, progettate per adattarsi rapidamente ai cambiamenti.
Nel frattempo, la minaccia informatica sta evolvendo e si sta professionalizzando a ritmi senza precedenti. È sempre più probabile che nei prossimi anni si verifichi un incidente globale di rilievo, legato a fughe di dati causate da un uso non sicuro dell’intelligenza artificiale: tale evento potrebbe rappresentare un forte campanello d’allarme, spingendo il settore a definire standard di sicurezza specifici per l’IA e a collaborare esclusivamente con partner tecnologici affidabili.
Anche le frodi nel trasporto merci e i furti di carico stanno registrando un incremento, in particolare nel Nord America, dove gruppi criminali sfruttano domini falsi e schemi di impersonificazione per colpire operatori e spedizionieri. Ciò sottolinea l’urgenza di implementare sistemi di verifica più rigorosi e procedure di qualificazione dei vettori basate sull’IA, in grado di prevenire interruzioni costose e danni reputazionali.
La migrazione verso piattaforme cloud potenziate dall’intelligenza artificiale rappresenta oggi una leva strategica per rafforzare la sicurezza aziendale senza incrementare eccessivamente i costi operativi.
Nessuna organizzazione, tuttavia, è immune: anche le realtà di grandi dimensioni restano vulnerabili a causa di infrastrutture IT obsolete. La priorità diventa quindi investire in architetture cloud scalabili e in standard condivisi per la gestione dei dati, elementi fondamentali per costruire una resilienza digitale e sostenibile nel lungo periodo.
5. Ecosistema connesso: dai dati all’azione
Una parte significativa delle inefficienze del settore deriva ancora oggi dalla mancata condivisione dei dati tra gli attori della filiera, sebbene il livello di apertura vari a seconda delle aree geografiche, la competitività globale sta progressivamente spingendo verso una maggiore collaborazione tra operatori.
I vettori continuano a considerare alcune informazioni come asset proprietari e quindi riservati, ma il potenziale di beneficio collettivo che deriverebbe da una maggiore trasparenza sta diventando sempre più evidente.
La creazione di ecosistemi digitali interconnessi, capaci di garantire uno scambio dati fluido e sicuro tra tutti gli stakeholder, rappresenta il passo decisivo per liberare il vero potenziale della digitalizzazione: una visibilità end-to-end in tempo reale che consente di prendere decisioni più rapide, informate e sostenibili, migliorando al contempo l’efficienza economica complessiva della supply chain.
In definitiva, maggiore è il livello di integrazione, maggiore è il valore condiviso generato. In un ecosistema davvero connesso, tutti gli attori della catena logistica ne traggono vantaggio.
Guardando al 2026
Se il 2025 è stato l’anno della sperimentazione, il 2026 sarà quello dell’accelerazione.
L’intelligenza artificiale raggiungerà una nuova fase di maturità operativa, superando la logica dei progetti pilota per diventare un motore di trasformazione profonda all’interno delle organizzazioni. La sostenibilità si concentrerà sempre più su strategie pragmatiche e allineate alla redditività, mentre la resilienza dipenderà in egual misura dalla capacità di valorizzare le infrastrutture cloud e dall’investimento nella qualità dei dati.
In definitiva, il futuro premierà le aziende che sapranno abbracciare ecosistemi realmente connessi, preservare l’integrità dei propri dati e, soprattutto, coinvolgere le persone nel percorso di trasformazione.